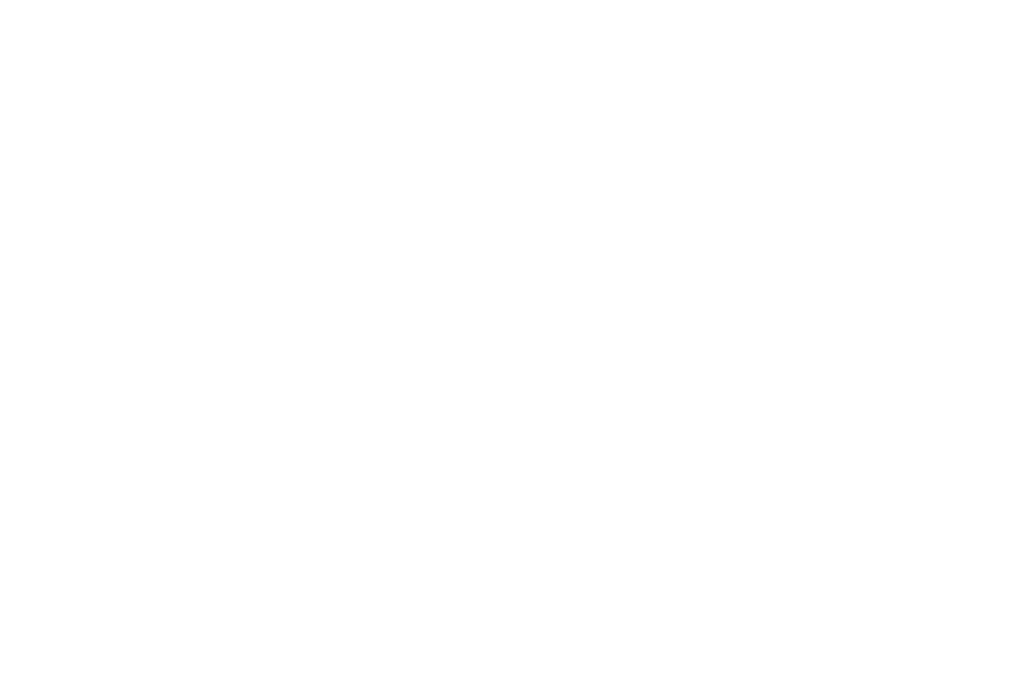nel cuore del Parco Naturale dei Colli Euganei
Arquà Petrarca
Il tempo sembra essersi fermato ad Arquà Petrarca, il villaggio dei Colli Euganei che mantiene inalterato il suo antico fascino medievale. Il suo nome deriva forse da “Arquata montium”, che significa “chiostra dei monti”, ma deve la sua notorietà alla fama eterna di Francesco Petrarca, il poeta che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita.
pillole dal passato
La storia del borgo
In un documento del 985 si attesta, ad Arquà, l’esistenza di un castello abitato da Rodolfo Normanno. Proprio sull’altura dove sorgeva questa fortificazione, oggi ricordata con il nome di Monte Castello, si identifica il nucleo medievale originario da cui si sviluppò il borgo che più tardi avrebbe ospitato Francesco Petrarca. Nel Duecento, Arquà divenne un feudo dei Marchesi d’Este, per poi passare sotto l’influenza politica di Padova. Successivamente, la signoria Carrarese elevò Arquà al rango di vicaria, ed è in questo periodo che il borgo ebbe l’onore di accogliere il Poeta e, dopo la sua morte, di conservarne le spoglie.
Sotto il dominio della Serenissima, instaurato nel 1405 in seguito alla caduta dei Carraresi, Arquà mantenne intatta la sua ampia giurisdizione vicariale, che comprendeva diversi centri dell’area euganea, tra cui Galzignano, Montegrotto, Abano e Valbona. Durante questo periodo, la crescente fama di Petrarca e il fascino esercitato dalla sua figura spinsero molte famiglie aristocratiche padovane e veneziane, come i Contarini, i Pisani, i Capodivacca e gli Zabarella, a costruire eleganti dimore nel borgo. Fu così che Arquà completò l’assetto urbanistico che conserva ancora oggi. Dopo il XVI secolo, il paese conobbe una fase di relativa stasi edilizia.
Con la caduta della Repubblica di Venezia, Arquà perse progressivamente la sua importanza. Solo nel 1866, in seguito all’annessione del Veneto al Regno d’Italia, il borgo fu elevato alla dignità di Comune e, nel 1868, ottenne il diritto di aggiungere al suo nome quello di Petrarca, in omaggio al grande Poeta.
Il poeta e i colli Euganei
Arquà e il Petrarca
È probabile che Francesco Petrarca abbia conosciuto Arquà per la prima volta nel 1364, durante il suo soggiorno ad Abano, dove si recò per curarsi alle terme. Nel 1369, Francesco il Vecchio donò al Poeta un appezzamento di terreno ad Arquà, quando questi, dal 1365, era divenuto canonico presso la collegiata della vicina Monselice. Già nella primavera dello stesso anno, Petrarca si recò personalmente ad Arquà per sovrintendere ai lavori di restauro di una casetta, che avrebbe iniziato ad abitare a partire dal marzo del 1370.
Arquà, al tempo del Petrarca, è descritta in un documento conservato nel Museo Civico di Padova come un luogo di grande bellezza naturale: “Vasti boschi di castagni, noci, faggi, frassini e roveri coprivano i pendii di Arquà, ma erano soprattutto la vite, l’olivo e il mandorlo a contribuire a creare il suggestivo e tipico paesaggio arquatense.”
Questa rigogliosa vegetazione e la pace del luogo probabilmente richiamavano alla mente del Poeta un’altra terra a lui cara, la Toscana. Fu forse per questa ragione che decise di stabilirsi in una dimora decorosa, certamente distinta dalle più umili abitazioni dei contadini e degli artigiani del borgo.
Tuttavia, il nome di Arquà non è legato esclusivamente alla figura di Petrarca. Numerosi notai e religiosi provennero da questo borgo, sebbene il più illustre sia stato Jacopo d’Arquà, membro della famiglia Paradisi. Medico presso la corte del re Lodovico d’Ungheria, Jacopo fu collega di Giovanni Dondi dall’Orologio, un caro amico del Poeta.
La casa del Petrarca
La struttura originaria della casa risale al Duecento, ma fu Francesco Petrarca, a partire dal 1369, a sovrintendere personalmente ai lavori di restauro, dopo che l’immobile gli era stato donato dal Signore di Padova, Francesco il Vecchio da Carrara. La casa, composta da due corpi distinti con un dislivello di tre metri e mezzo, fu modificata dal Poeta per trasformarla in un’unica residenza articolata in due unità abitative.
Petrarca riservò per sé e per la sua famiglia il piano sopraelevato dell’edificio sul versante di sinistra, mentre destinò l’edificio di destra, posto più in alto, alla servitù e ai servizi. Quest’ultimo ospitava anche l’ingresso principale.
Nel Cinquecento, la proprietà passò al nobile padovano Pietro Paolo Valdezocco, che apportò ulteriori modifiche: vennero costruite una loggetta in stile rinascimentale e una scala esterna, mentre le pareti furono decorate con tempere raffiguranti scene ispirate al Canzoniere, ai Trionfi e all’Africa.
L’ultimo proprietario, il cardinale Pietro Silvestri, donò la casa al Comune di Padova nel 1875. Oggi, l’edificio conserva ancora lo studiolo in cui il Poeta morì, con la sedia e la libreria che si ritiene siano originali. Degna di nota è anche la nicchia che custodisce la mummia della gatta, che la tradizione vuole fosse appartenuta a Petrarca.
.